
Il 2019 e il conflitto sociale tra cinema, televisione e videogioco

Quello che ci lasciamo dietro è un periodo particolare. Il 2019 ha segnato la comparsa di molti temi in grado di condizionare gli anni a venire, su tutti quello ecologico; anche dal punto di vista della cronaca politica verrà ricordato, e non solo per l’ennesima litigata nel condominio Italia, ma anche e soprattutto per le elezioni inglesi, la nascita di una nuova Commissione Europea, la delicata situazione di Trump negli Stati Uniti. Ma c’è di più. Quest’anno ci ha dimostrato una cosa: è ancora possibile criticare la struttura della nostra società, e che l’arte – soprattutto visiva – è perfettamente in grado di farlo raggiungendo i propri interlocutori naturali. Non tanto e non solo limitandosi alla cosiddetta “woke culture“, dall’utilità indubbia ma che spesso si sofferma troppo sulle sovrastrutture, bensì andando in profondità e analizzando la disparità che deriva da una sempre più disomogenea distribuzione della ricchezza, da un mondo gestito da e per chi detiene il potere economico – nell’accezione weberiana del termine – e dallo sfruttamento del prossimo.
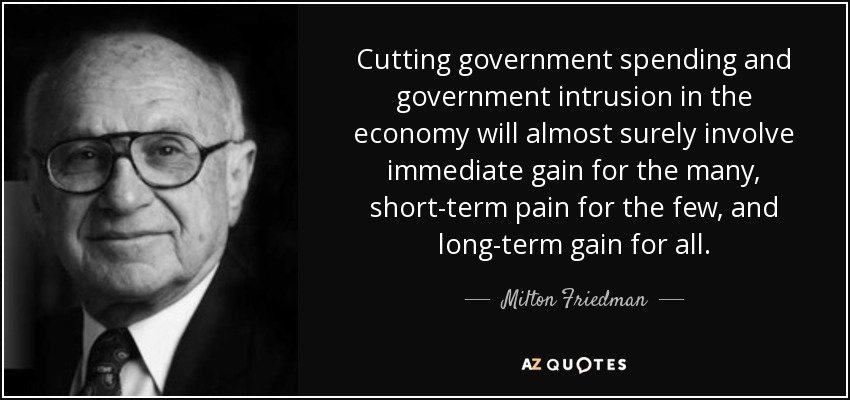
Se c’è qualcosa che gli americani hanno prodotto, nell’ultimo ventennio, è lo straniamento di fronte a questi temi e l’incapacità di trovare il vero punto di ogni discussione, complice anche l’aver scardinato scientemente qualsiasi residuo di coscienza di classe all’interno dei vari gruppi sociali in cui si divide la società civile.
Di nuovo: si è troppo spesso finiti a questionare solo di sovrastrutture.
Si prenda ad esempio l’affaire Weinstein che, analizzato sotto la luce della “pura” dinamica di genere, riesce a spostare l’asse di lettura così tanto da dimenticarsi di bastonare un sistema che consente un livello di subordinazione del dipendente rispetto al datore di lavoro tanto profondo da raggiungere la sfera intima. L’insegnamento che dovremmo trarre è quello di appartenere oggi a una comunità progredita spesso solo virtualmente e che, invece, nei concreti rapporti interpersonali o lavorativi si dimostra primitiva, iniqua e disgustosa a tutti i livelli; costante è la violenza tra chi detiene i mezzi di produzione e chi, invece, è al soldo di questi ultimi, al di là di tutti i formali riconoscimenti borghesi sanciti nelle carte del globo terracqueo. Ridurre una problematica economica-sociale a una di genere – che senz’ombra di dubbio esiste, ma risulta essere corollario e non teorema – conduce unicamente ai risultati spesso aberranti e falsamente risolutivi tanto cari al mondo occidentale, a cui interessa che le fondamenta del palazzo non vengano colpite: per il resto, si discuta di ciò che si vuole. La fine degli anni dieci sembra aver realizzato – in modo più massiccio del recente passato – un segno di discontinuità: in altre parole, registi e game directors hanno iniziato a criticare il capitalismo.

In questo contesto urbano si muove Arthur Fleck, un fantasma tra i fantasmi, ognuno vestendo, rivestendo e svestendo la funzione dettata dal proprio reddito.

Dicevamo della consapevolezza. In Parasite emerge un protagonista collettivo, e cioè una famiglia sull’orlo del collasso, verso cui la lotteria sociale tanto cara a John Rawls non è stata affatto morbida. Sono loro al centro delle vicende e non il singolo individuo: la disperazione non è più dell’ “uno” abbandonato dalla comunità, ma dell’intera formazione sociale che è messa ai margini e costretta a vivere di espedienti. Trascorso il primo – agrodolce – atto, la pellicola si muove su binari sorprendentemente differenti e visualizzati, metaforicamente, dal bunker sotterraneo: pochi metri che separano l’alta borghesia e gli scarafaggi umani, destinati a non incrociarsi mai se non per brevi atti, riconosciuti dai rampolli della nuova classe dominante non più come uomini ma come fantasmi, deturpati nel corpo e nello spirito. La cornice si arricchisce anche della feroce lotta interclasse, degli ultimi che litigano per le briciole cadute dal tavolo dei primi, con l’intera pellicola che sembra sempre sul punto di rompere i propri schemi visivi rivelando come la bellissima casa in stile van der Rohe non sia nient’altro che un costante e gigantesco simbolismo che si propaga per poco più di due ore. E poi si sa che i poveri puzzano, come ci ha ricordato anni fa il dottor Casalino, a questo punto accreditato tra le maggiori ispirazioni di Joon-Ho.

Decisamente interessanti risultano poi essere le succedanee riflessioni su chi detenga effettivamente il controllo di determinati processi storici, e quanto le inclinazioni dei tanti vengano distorte per favorire l’emersione di interessi di una classe spesso non così distante da quella che si voleva abbattere, in modo non dissimile a quanto accaduto con l’eredità della Rivoluzione Francese, divenuta appannaggio unicamente della borghesia e le cui aspirazioni solidaristiche troveranno sbocco solo un secolo e mezzo dopo nelle varie carte costituzionali dei paesi europei sfuggiti al totalitarismo.

