Il Plusv-Aloy, tra fatturato e battaglie sociali

Horizon Forbidden West è stato accompagnato sugli scaffali da uno dei soliti stunt pubblicitari in pompa magna di Sony: mentre il gioco arrivava nei negozi è stata esposta prima a Firenze e poi in altre città italiane una statua della protagonista. Quest’ultima è diventata immediatamente pietra dello scandalo, per via della sua targa che indicava Aloy come The Placeholder, “un’icona di coraggio, tenacia e intraprendenza [che] tiene il posto a tutte le donne della Storia che hanno condiviso questi valori e meriterebbero una statua”.
L’accusa è duplice: Sony sta da una parte cercando di imporre Aloy come icona nel medium videoludico, mentre dall’altra cavalca la battaglia femminista col chiaro scopo di vendere più copie dell’ultimo Guerrilla.

Sony cavalca la battaglia femminista.
La prima critica è poco interessante da discutere, perché è facilmente debunkabile seguendo un semplice ragionamento. Aloy è un personaggio che fin dal suo annuncio è stato ostracizzato da una certa fetta di videogiocatori, erede di una mai davvero esaurita retorica figlia del Gamergate e che continua a riemergere dalle fogne ogni qualvolta che nel videogioco mainstream si affacciano rappresentazioni diverse dal maschio alfa e dalla damigella in pericolo, il più sessualizzata possibile.
Aloy è una protagonista femminile che non ha romance né relazioni sentimentali in-game, non indossa costumi che assecondano il male gaze e, addirittura, osa mostrare delle imperfezioni come macchie sulla pelle e peluria facciale. È quello che queste narrative descriverebbero come un personaggio politicamente corretto, pensato per trasmettere messaggi woke fin dal suo character design. E proprio per questo va presa di mire con polemiche, mod che ne vanno a snaturare il significato e wave di meme che la mostrano ingrassata.
Ad aver eletto Aloy come icona femminista è stata proprio questa gente: è il martirio del nuovo millennio, perfetto termometro di quelli che sono i problemi del medium e anche di quanto siano efficaci certe rappresentazioni. Perché altri personaggi nati – quelli sì – per essere token non hanno generato così tanto odio, e di conseguenza non hanno colpito egualmente nel segno.

Horizon è una critica al capitalismo creata dal capitalismo.
Quello che è importante discutere è il secondo punto. Perché l’accusa di strumentalizzazione da parte di Sony è assolutamente sensata, se si pensa per esempio alle posizioni agnostiche prese dall’azienda in materia di aborto – tali da costringere i singoli PlayStation Studios ad andare contro il diktat aziendale e a dichiararsi apertamente a favore, laddove Jim Ryan preferiva parlare di gattini.
È una questione di economicamente corretto
Non è una questione politica in senso stretto. Riguarda più i soldi, l’economicamente corretto, cui bisogna attenersi in nome del fatturato. Il tema dell’interruzione di gravidanza è un hot topic in quello che è il mercato principale per PS5, ovvero il Nord America. La partita in Europa è già data per vinta; non è un caso che infatti l’aumento di prezzo della macchina abbia interessato il Vecchio Continente lasciando il listino invariato negli Stati Uniti. Con l’occhio ai fatturati scegliere di schierarsi su una tematica come l’aborto sarebbe controproducente: non è una battaglia già digerita (e quindi tokenizzabile) come quella legata all’identita di genere. Dove, peraltro, il massimo dello sforzo quando si è quotati in borsa è cambiare la foto profilo sui social mettendo i colori del pride – tranne per le pagine per il mercato russo e quello mediorientale, ovviamente.
Qui c’è il rischio vero di perdere utenza e quindi punti in borsa, per cui grazie ma no grazie. A maggior ragione allora perché dovremmo lasciare che le aziende possano appropriarsi delle battaglie sociali quando fa comodo distribuire monetizzare opere che le trattano?
Perché lasciare che Sony capitalizzi sulla causa femminista? Oppure che Amazon si comporti come la Vought mentre The Boys diventa il suo prodotto streaming di punta? Ancora, che Konami pubblichi un videogioco dov’è centrale il discorso sull’importanza della parola mentre costringe Hideo Kojima al silenzio stampa? Perché non abbiamo alternative.
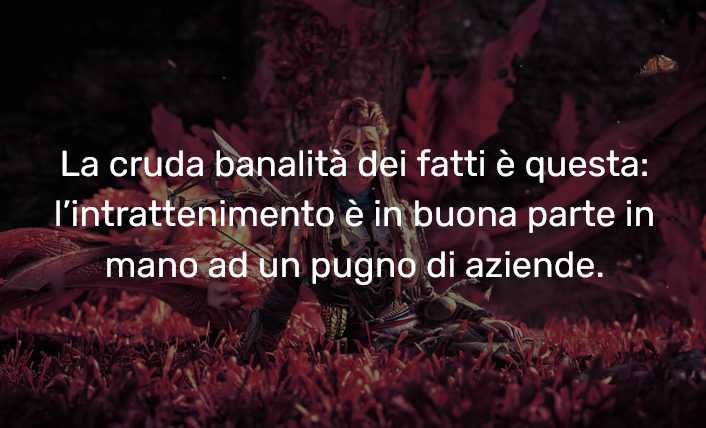
Se vuoi che qualcuno veda il tuo film o la tua serie TV deve stare su Netflix. Se vuoi che la tua musica raggiunga il grande pubblico devi pubblicarla su Spotify. Se vuoi anche solo poter sperare che il tuo videogioco venga notato da qualcuno, in quest’epoca dove il self publishing ha frequenze così alte da distorcere completamente la forma d’onda delle homepage degli e-store videoludici, devi avere alle spalle qualcuno di grosso. Anche il tuo piccolo videogioco – perché l’indie ha smesso di essere tale due generazioni fa e le aziende fanno presidio anche in questa fascia – serve a rimpolpare l’offerta di Game Pass o banalmente a riempire la lineup di esclusive temporali nei mesi vuoti. A maggior ragione poi se sei parte di uno studio affermato che ha bisogno di un budget di cento milioni di dollari per tradurre il suo concept su disco. Cento milioni e tanto supporto a livello di marketing, perché sì, de facto l’idea è quella di un The Witcher 3 all’acqua di rose con i dinosauri meccanici, ma la protagonista è – appunto – Aloy, cioè il primo vero passo fatto dal videogioco mainstream verso una rappresentazione più positiva del corpo femminile.
In uno scenario del genere non ci sono alternative. O meglio, l’alternativa è una sola: decidere deliberatamente di non dire quello che si pensa, non fare quello che almeno qualcuno in Guerrilla deve aver creduto essere necessario fare, perché non si decide di combattere una guerra se almeno qualcunə non ha la giusta motivazione. E quando uno sviluppatore decide per il silenzio magari vivrà una vita più tranquilla, senza minacce di morte nella casella di posta o Face Rework Mode in tendenza sui portali, ma rende le nostre vite meno significative.

Doppia Aloy, doppio messaggio.
È la mente creativa quella che firma questo patto col diavolo, non noi. Non ci viene chiesto di accettare il marchio della Bestia sul nostro corpo e di portare le stigmati del capitalismo. Tutto quello che ci viene chiesto – tutto quello che dovremmo fare – è non abbandonare i simboli di cui il capitalismo si appropria. È così che diventano davvero dei token, quando decidiamo deliberatamente di annullarne il significato sulla base di un compromesso che ci arroghiamo il diritto di fare nostro quando non lo è.
Abbiamo già i nostri martiri: dobbiamo solo scegliere di renderli degni di culto.
PI
