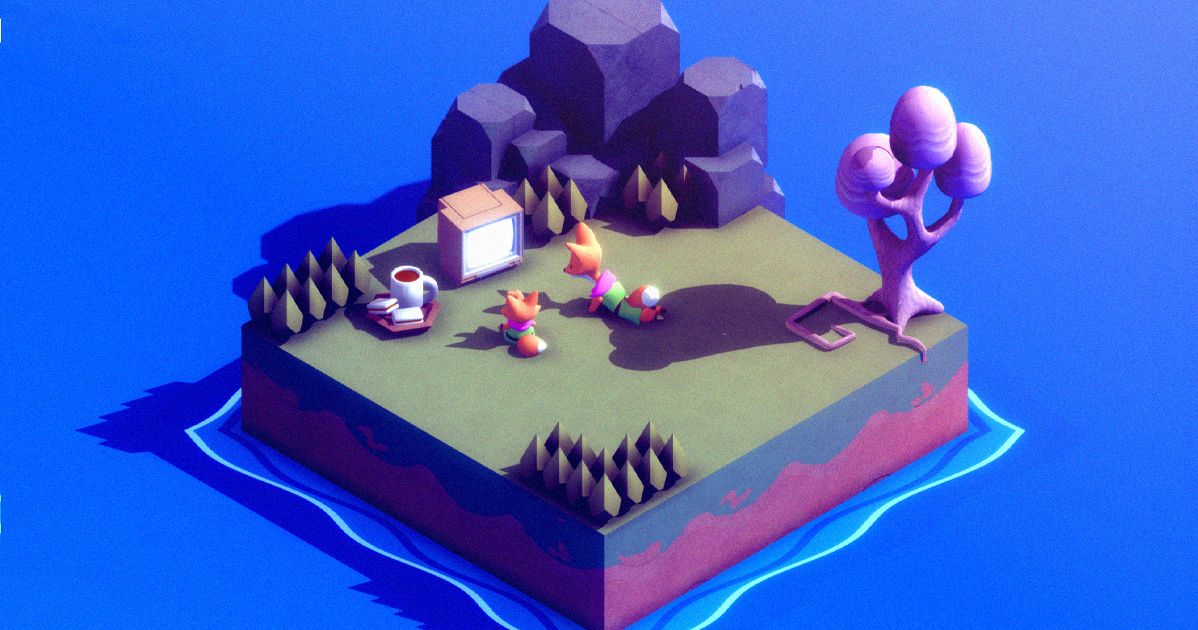Cosa ci rimane di Horizon Forbidden West
Cosa ci rimane di Horizon Forbidden West

Il seguente articolo su Horizon Forbidden West è da considerarsi come continuazione di un dialogo iniziato nel lontano 2017. Pur essendo autonomo, non possiamo che consigliare la lettura di questo precedente pezzo a chi voglia approfondire ulteriormente il collegamento tra il secondo e il primo capitolo della saga di Aloy, soprattutto in termini tematici.
Cinque anni: questo è il tempo trascorso tra i due Horizon, Forbidden West e Zero Dawn. Di acqua ne è passata sotto i ponti – compreso il lancio di una nuova generazione di console – e soprattutto è cambiato chi concorreva, nella finestra di uscita, proprio con il lavoro di Guerrilla. Al tempo che fu, c’è stato il colossale The Legend of Zelda: Breath of The Wild; adesso, l’attenzione è focalizzata – per non dire fagocitata – da Elden Ring, l’opera di From Software che ha ridefinito, una volta e per sempre, il rapporto tra i Souls e l’Open World.
Parlare di Horizon Forbidden West paragonandolo con i titoli a esso contemporanei è un po’, sadicamente, il tratto distintivo della produzione. “Non” è forse la prima cosa che salta in mente quando si discute di Horizon: “non è Zelda”, “non è Elden Ring”. Esiste in primis come negazione: ne sono stabiliti i confini per opposizione, ridimensionandolo di fronte ai capolavori. Questo atteggiamento, forse, ha creato le basi di una subalternità non solo intellettuale, ma addirittura afferente lo spirito con cui il videogioco viene approcciato; e ciò vale sia per i fruitori che per la critica.

Questa volta si va in California.
Non che in questa sede si voglia tirare la volata a Horizon perché è meglio dei due sopra citati, sia chiaro; lasciamo volentieri ad altri questo ingrato compito, e pure di cavarsi fuori dal correlato ginepraio. Epperò, una cosa va chiarita subito: la tempistica di rilascio di Forbidden West – e di Zero Dawn – ha sicuramente inciso nella valutazione complessiva del lascito, e del significato più intimo, dei due videogiochi dello studio olandese. Essere usciti assieme a una coppia di colossi, soprattutto in quanto avvertiti immediatamente come tali da parte del grande pubblico e da chi dovrebbe occuparsi di analisi critica, ha inevitabilmente impattato anche sulla percezione di Zero Dawn e Forbidden West. Ma questo è solo il primo dei due tasselli che compongono quel “non” di cui si scriveva poc’anzi.
A questa trappola, in verità, non è sfuggito nemmeno lo stesso Pop-Eye, che pure fa del rifiuto della hype culture uno dei suoi fondamentali. Abbiamo scritto per Elden Ring ben tre articoli: un provato e una riflessione sul world building a cura di quella penna evocativa che è Vincenzo Vecchio, e il cerebrale apporto di Vito Carluccio, che ha ragionato dell’open world realizzato da Miyazaki e co. Per Horizon Forbidden West, invece? Uno solo, firmato da Giacomo Temperini, in cui doveva pure smezzarsi il palcoscenico con l’altro Horizon, quello targato Playground Games. Dunque non ci sentiamo particolarmente esenti dal fenomeno descritto nel paragrafo precedente, e alla questione “allocazione delle risorse critiche” che abbiamo peraltro sollevato.
In realtà, l’articolo di Giacomo toccava un punto fondamentale. Nella sua disamina, suggeriva che una determinata struttura ludica – e il corrispondente ciclo del gameplay – fossero elementi ricorrenti in molte produzioni moderne, originate più o meno consapevolmente dal concept Ubisoft: Horizon Forbidden West sarebbe una di quelle. Il pattern che si presenta in questi videogiochi è più o meno costante, generando uno stimolo svuota-mappa e differendo le esperienze in base a fattori perlopiù estetici che, quindi, diventano identitari.

L’estetica techno-cafonal crea un limite percettivo?
Ora, per non scadere in una miserabile autoreferenzialità, bisogna tirare le somme. Il fatto è che, banalmente, i temi a cui si accompagna Horizon Forbidden West sono così esplosivi da non giustificare la narcosi successiva delle varie comunità, anche quelle più impegnate politicamente. Qualcosa fa massa, non torna: e non è possibile risolvere questa perplessità con il solo “erano tutti a giocare a Elden Ring”. O meglio, funziona solo in parte. Ci dev’essere altro: e se i due colpevoli fossero proprio gli elementi distintivi di Horizon, e cioè il deja-vu ludico adottato da Guerrilla e l’estetica techno-cafonal?
La risposta è probabilmente sì. Nel caso di Horizon, la forma ha assorbito il contenuto, decretando la stessa capacità del sequel di Aloy di essere avvertito come veicolo di messaggi importanti. D’altronde siamo spesso portati a prendere sul serio ciò che si prende a sua volta sul serio: un videogioco che si presenta con delle macchine robot all’interno di uno scenario tribale e coloratissimo, beh, da quel punto di vista non aiuta. Eppure, in Horizon Forbidden West viene ripresa e ampliata una prospettiva anticapitalista, già presente nel primo episodio, che qui raggiunge vette davvero importanti e su cui vale la pena di riflettere.
Insomma, ci siamo capiti: la contemporaneità con Elden Ring (e Zelda) ha spostato l’attenzione, mentre il presentarsi prima facie come un baraccone ha fatto il resto. Se il primo aspetto è ormai consegnato alla storia, il secondo può essere invece ancora indagato, allo scopo di prevenire che avvenga ugualmente in futuro. Perché, in Horizon Forbidden West, gli scrittori di Guerrilla hanno calcato così tanto la mano su certi topoi, palesando il proprio pensiero, da far derubricare la mancanza di attenzione collettiva più come a un misto di brutto tempismo e pregiudizio da parte di fruitori e critica che a una mancanza degli autori stessi. Horizon prova a farsi capire; siamo noi a non volerlo afferrare. Non è questione, va sottolineato con forza, di limiti culturali, bensì di atteggiamento.

Tutto questo sfarzo può ritorcersi contro.
L’intento di questo articolo è, quindi, quello di provare a ricostruire i punti di fascino di Horizon Forbidden West, emancipandolo dall’aura di mero giocattolone – che pure in parte è – evidenziando sia quello che dice che come lo dice, cioè l’espressione di quel messaggio attraverso l’impalcatura videoludica.
Più che nell’Ovest proibito andremo nel Sud lecito. E sì, questo è un modo carino per chiedervi di continuare a leggere più in basso.
Un’oncia di azione vale quanto una tonnellata di teoria
[DISCLAIMER: di qui in poi l’articolo contiene SPOILER su Horizon Forbidden West]
Verbena, un’ereditiera; Stanley Chen, imprenditore e visionario; Gerard, uno degli uomini più ricchi della Terra e alla guida di un conglomerato industriale; Erik, proprietario di un’agenzia militare privata. Questa lista di proscrizione non contiene altri nomi che quelli degli antagonisti di Horizon Forbidden West, i cosiddetti Zenith. Una banda di capitalisti senza controllo, a cui va ad aggiungersi Tilda van der Meer, mecenate e buco nero dell’egoismo mondiale, incarnatosi incredibilmente in una singola donna. Al videogiocatore, gli scrittori di Guerrilla propongono come nemici, avversari, pericolo per la vita biologica stessa, le persone più facoltose del pianeta. Che vengono dipinti, pur con qualche intermezzo democristiano – tra cui figura la quest di Alva – quali veri e propri mostri.
Dopo un primo capitolo che, nemmeno tanto timidamente, aveva già avanzato critiche profonde nei confronti delle figure messianiche à là Elon Musk – di cui Ted Faro costituisce una protesi videoludica, voluta o nata da una combinazione decisamente troppo fortunata per credere che non sia così- e diventate un po’ il simbolo di questa new wave del capitalismo mondiale contemporaneo, nel sequel Guerrilla ha alzato il tiro. E di parecchio. Horizon Forbidden West sembra quasi voler investigare nella dimensione antropologica del capitalista, disegnandolo come un soggetto lacerato all’interno e logorato dal suo immane istinto di appropriazione. Un’appropriazione che lo rende non solo tanto egoriferito da dubitare della sua salute mentale, ma anche profondamente disumano.

Gli Zenith, meglio morti che vivi.
Abbiamo di fronte, quindi, qualcosa di molto simile a quello che Helen Hindpere e compagni (nel senso più pieno del termine) avevano fatto dire a un certo personaggio, in un certo videogioco:
The mask of humanity fall from capital. It has to take it off to kill everyone — everything you love; all the hope and tenderness in the word. It has to take it off, just for one second. To do the deed.
da Disco Elysium, ZA/UM, 2019
La stessa violenza perpetrata da Aloy sembra quindi cambiare le coordinate di senso, e non esistere più solo in quanto potenza distruttiva legata alle esigenze del videogioco e del videogiocatore, ma come vero e proprio atto di autodifesa. Il che richiama altre parole, questa volta di un – purtroppo – non famosissimo pensatore italiano:
(…) perché due vivano in pace bisogna che tutti e due vogliano la pace; ché se uno dei due si ostina a volere colla forza obbligare l’altro a lavorare per lui ed a servirlo, l’altro se vuol conservare dignità di uomo e non essere ridotto alla più abbietta schiavitù, malgrado tutto il suo amore per la pace ed il buon accordo, sarà ben obbligato a resistere alla forza con mezzi adeguati.
Errico Malatesta, Pensiero e Volontà, 1924
Il mondo di Horizon è profondamente tormentato dalle remote scelte sbagliate di un sistema fallato, che per inseguire il profitto aveva condannato il pianeta già in passato; e ora torna in tutta la sua ferocia, direttamente dalle stelle. Atterra su un nuovo-vecchio mondo per decidere, ancora una volta, le sorti di qualcosa che aveva già distrutto. E allora, davanti a un debito che non spetta pagare, di fronte alla subiezione intrinseca ai padroni, non rimane altro che reagire. In questo senso, Horizon appare come un videogioco marcatamente europeo.
Questo passaggio richiede un approfondimento ulteriore. Mentre Horizon Forbidden West da un lato si fa portatore di istanze progressiste, e cioè utilizza il mondo fittizio per veicolare messaggi riguardo l’identità di genere, sessuale e l’allargamento dovuto delle cosiddette libertà liberali, dall’altro opera una riflessione che impatta direttamente sul conflitto di classe; o, comunque, sulle difficoltà in cui incappa una comunità dove esiste una forbice molto larga tra chi possiede le risorse e chi, al contrario, le subisce.

Aloy è in primo piano, ma esistono anche gli altri.
Lo sforzo di operare una sintesi tra le pulsioni individualistiche, tipiche della tradizione anglosassone, e la necessità di configurare l’attività umana anche in senso di collettività, proveniente dall’Est, ha rappresentato il tratto distintivo del Vecchio Continente durante tutto il secondo dopoguerra, se non proprio l’intero secolo breve. Le persone in Guerrilla pare ricordino che i diritti civili, senza diritti sociali, restano diritti individuali.1
Andando più nello specifico, si potrebbe rilevare come l’eccezionalità e la caparbietà di Aloy vengano costantemente riconosciute durante il corso dell’avventura, così com’è sottolineato che non sia tanto il corredo genetico di una persona ma l’insieme di valori e di esperienze, da cui gli stessi sono maturati, a renderla tale (e su questo torneremo poi). Contemporaneamente, Aloy è considerata una pedina necessaria ma non sufficiente, che solo attraverso l’aiuto degli altri, un’organizzazione formata da più persone, riesce a portare a termine il proprio incarico.
L’essere umano esiste sia in quanto soggetto dotato di qualità uniche e non replicabili, da preservare e curare, sia in quanto corpo inserito all’interno delle formazioni sociali, le cui necessità devono essere tenute in conto e sono necessarie all’avanzamento della specie. Questo è il difficile equilibrio continentale, capace di rigettare un modello basato solo sull’esasperata soggettività, ma pure quello antiteticamente fondato sull’annullamento della stessa. Lezione, d’altronde, recepita dalle carte costituzionali europee che, accanto alle libertà individuali, accolgono la visione dell’uomo all’interno di organismi complessi (associazione, partiti politici, famiglia ecc.).

Aloy, Tilda e la funzione dell’arte.
Lo squilibrio – questa volta non delle macchine, ma tra queste due forze contrapposte – produce le Tilda van der Meer di questo mondo. E cioè delle persone davvero orribili, che si approcciano all’arte e all’alterità in maniera esecrabile: volendo, cioè, possedere tutto, senza differenze tra quadri e viventi. Eppure la sua bulimia culturale avrebbe dovuto mettere in guardia il videogiocatore; se già Walter Benjamin (L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 1936) aveva avvertito dei cambiamenti percettivi collegati alla modifica del luogo di esposizione dell’opera, trovare dei Vermeer e dei Rembrandt a casa di una ricca opulenta – per soddisfare un solitario godimento – li deforma definitivamente. Diventano, infatti, nient’altro che masturbazione intellettualoide, strumenti di auto-affermazione e non di condivisione; un gioco che si fa per costruire l’immagine di sé.
Non è un caso che, nella meravigliosa scena della galleria privata, ci siano solo dipinti del Secolo d’oro della pittura olandese: il Seicento è anche il periodo della nascita del capitalismo mercantile proprio nei Paesi Bassi, l’antesignano del sistema attuale. Un altro filo rosso, un’eredità che resiste a chi l’ha fisicamente creata; esattamente come Nemesis, lo spirito del capitalismo che si abbatte di nuovo sulla Terra e da cui gli stessi creatori volevano sfuggire. Utilizzando, ancora una volta, il pianeta come mezzo e non fine.
Che fare?
Stabilito quindi ciò di cui parla Horizon Forbidden West, è tempo di investigare come sono espressi questi temi: di sottoporre a critica la struttura ludica e il linguaggio adoperato per veicolare il messaggio.
Prima di farlo, però, è opportuna una digressione. I due piani analitici sono quello esistenziale, quantitativo, e il corrispettivo modale, qualitativo.

Aloy e Beta; Vermeer e la sua copia.
Più chiaramente: bisogna capire se il lavoro di Guerrilla propone dei temi all’interno nel comparto narrativo tradizionale (cutscene delle quest principali, ad esempio) che sono assenti nel giocato, oppure se, semplicemente, quei temi sono sì presenti ma tendono ad affogare in un mare di contenuti, dispersivo e caciarone. Ci passa la differenza tra raccontare male o non farlo affatto: se un videogioco propone la centralità di alcuni argomenti e poi li ignora clamorosamente per la più gran parte del tempo, non sta curvando il game design in funzione degli obiettivi che si è autoimposto. E viene a mancare quella prospettiva teleologica di cui abbiamo parlato più volte.
Tornando alle considerazioni espresse in apertura di articolo, è fondamentale ribadire che l’accostamento di Horizon Forbidden West a un titolo spazialmente organizzato come Ubisoft insegna, è quantomai condivisibile. Guerrilla ha, però, inserito tracce del discorso che prova a portare avanti in quasi ogni attività, dai collezionabili alle secondarie: ha provato a stringere il cappio dell’offerta ludica attorno all’attività antropica capitalista. La stessa che ha agito sulla biosfera, distruggendola prima e rischiando di farlo nuovamente poi. Insomma, ha spremuto una formula rodatissima – e che dimostra ancora di saper vendere sul mercato – basata sul bigger is better, tentando di renderla compatibile con il comparto narrativo.
Per farlo, ha adottato delle soluzioni classiche basate sui raccordi ludonarrativi. Ad esempio, l’urgenza della missione di Aloy viene raffreddata da Gaia, che sposta la fine del mondo di lì a qualche mese, creando lo spazio per evitare contrasti tra obiettivi del personaggi e girovagare del videogiocatore. Ancora, inizialmente, nel Timore, viene bloccato il ciclo giorno-notte in virtù della presenza di un obiettivo urgente, così da far apparire ogni deviazione rispetto all’impellenza di trama comunque risolta durante una sola giornata. Dopotutto, la stessa rigidità dei sistemi di arrampicata, resi più smooth dai tempi di Zero Dawn ma comunque ben distanti dalla sensazione di totale libertà presente in Breath of the Wild, rinforza l’idea che in Guerrilla abbiano cercato una via mediana tra l’esplorazione fine a se stessa e un’esperienza più focalizzata, per quanto possibile; cosa che si riflette anche sul quest design, e non sempre brillantemente.

L’arrampicata, più croce che delizia.
I due aspetti che però più colpiscono, sono esterni alla tradizione.
Il primo riguarda la potenza narrativa delle boss fight, che acquisiscono un significato importante grazie all’illuminazione fornita dai ruoli dei personaggi; in quella conclusiva, Aloy combatte per non essere ridotta a oggetto, usando violenza contro chi non la considera come una persona. Al contrario, con Erik, l’uso della forza diviene legittimo per sfuggire al braccio armato del capitale, quello che non accetta alcuna mediazione.
Tornano, insomma, i concetti lacaniani del “discorso del capitalista” e del “discorso del padrone”, con la dialettica ottocentesca, tipica del servo-padrone, che cede il passo a quella della sfrenata corsa all’appropriazione, ben descritto dall’euforismo maniacale di Tilda van der Meer2. La quale, in effetti, vuole possedere la protagonista di Horizon Forbidden West; e così Aloy si ritrova, simbolicamente, a combattere con le due facce storiche del capitale.
L’altro aspetto riguarda le potenzialità delle periferiche per enfatizzare i temi del videogioco, una prospettiva interessante soprattutto per i prossimi anni. Il poter sentire il mondo attraverso le mani grazie al DualSense costruisce, nel videogiocatore, un legame emotivo con la natura, da proteggere e preservare a ogni costo. Far tuffare Aloy nell’acqua caraibica della Baia di San Francisco, ricevere un minuscolo feedback percettivo delle onde che confonde il cervello per un millisecondo, edificando un accostamento con il ricordo di una nuotata vera, crea dei sentieri non ancora battuti. Il dibattito attorno a queste nuove tecnologie si è davvero raramente incentrato sui riverberi narrativi delle stesse, e Horizon Forbidden West inizia a mostrare che possano essere qualcosa in più che mere gimmick.

Sì, dovevate fare di più.
Alla luce di ciò, risulta impossibile sostenere la mancanza esistenziale dei temi nel ventaglio di proposte ludiche, e davvero difficile ritenere la realizzazione così deficitaria da minare la comprensione del messaggio. Al contrario, si aprono scenari riflessivi importanti: Horizon rappresenta le multinazionali che inglobano e rivendono anche le critiche che sono a esse riferibili, come nel caso di Amazon e la serie The Boys, oppure è un cavallo di Troia che utilizza uno schema commerciale gradito alle corp per lanciare un missile?
E se ci fossimo già detti tutto e, quindi, l’unico modo per ribadire ciò che è importante sia incastonarlo all’interno di un contenitore che, per regola d’esperienza, non sarebbe adatto? Se fosse importante sensibilizzare anche attraverso la locura, perché digeribile da un numero enorme di persone?
Ecco, sarebbe il caso di iniziare a parlarne.
Complesse eredità e differenti percezioni
Come Guerrilla, anche noi decidiamo, in chiusura, di osare un pochino. Com’è universalmente noto, con “Meme”, “Gene” e “Scene” si è soliti riferirsi alle fondamenta della trilogia di Metal Gear Solid, quella composta dai primi tre capitoli e conclusasi, idealmente, con Snake Eater nel lontano 2004. Nella visione di Hideo Kojima, la costruzione del sé passa attraverso il rapporto con tre grandezze in realtà indisponibili al soggetto: la sua genetica (Gene), le informazioni (Meme) e il contesto storico in cui vive (Scene).

I ringraziamenti di Guerrilla a Kojima Production.
Dopo aver portato a termine le peripezie di Aloy, non è peregrino pensare che il rapporto tra Guerrilla e Kojima Production vada oltre la cessione del Decima Engine e che esista, invece, un’influenza e una stima capaci di estendersi anche ai contenuti. Horizon, tra tutti i Tripla A moderni, è quello che maggiormente riprende gli argomenti di Metal Gear Solid; e non è difficile identificare le tre grandezze appena descritte proprio in Forbidden West.
La distanza che separa due soggetti geneticamente identici come Aloy e Beta è data dalle esperienze di vita cui sono state entrambe sottoposte, e l’assetto valoriale che è stato, conseguentemente, generato. Non esiste alcun destino manifesto; e nemmeno il possesso dei geni di un altro rende quella persona, dominanti o recessivi che siano. Se già nel primo capitolo Aloy – Snake voleva emanciparsi in tutti i modi dalla predestinazione, qui arriva infine a distaccarsi da Elisabet – Big Boss e dalla sua eredità, quella Outer Heaven creata dal progetto Zero Dawn. Non pianifica un nuovo mondo ma cerca di salvare il proprio, mantenendolo integro dalla minaccia finale.

Dai geni di Liquid e Solid…
Come invece sottovalutare l’apporto delle informazioni nella creazione di una cultura? L’intero corso della tribù dei Quen è segnato da una lettura completamente fuorviante del passato, da una mitizzazione degli avvenimenti e dalla mancanza di accesso a dei dati considerati proibiti. Questo comporta manipolazioni e fanatismi, con importanti ricadute nel presente: addirittura il titolo di Amministratore delegato (CEO) diventa sacrale. Crea una religione, in vece di una comprensione ragionevole dei fatti; e, di converso, modella la società in maniera deforme. La stessa vicenda del database Apollo, finalmente recuperato, assurgerà a un ruolo centrale nel capitolo conclusivo della saga.
Per ultimo, Scene. Ricavata stavolta dal presente – cui Guerrilla ha saputo dare una rinnovata dignità scuotendolo dall’encefalogramma piatto di Zero Dawn – è ben descritta dal ruolo di Regalla, dalla funzione di burattinaio destinata a Sylens e dal concetto di “grand scheme of things” in cui ogni persona ricade, volente o nolente. Le relazioni tra esseri umani sono indirizzate non solo dal corredo naturale e dalle informazioni che generano la percezione delle cose, ma anche e soprattutto dalla realtà dove si è calati; il conflitto tra Carja e Tenakth non è diverso. Una vera e propria Guerra Fredda che si muove tra intransigenza e distensione, e in cui ognuno recita una parte.

…a quelli di Aloy e Beta.
Horizon Forbidden West è, dunque, un gioco interessante e che merita un palcoscenico importante all’interno del discorso videoludico, che sappia ritornare sui suoi pregi ed evidenziare i tanti difetti.
Rispondendo alla domanda (implicita) che dà il nome all’articolo, di questo sequel ci rimane intanto una certezza, che è quella di un importante indirizzo politico-riflessivo adottato da Guerrilla. Ma anche, e soprattutto, un’amarezza: l’abito fa ancora il monaco3. Spetta alla critica spezzare il pregiudizio, o almeno a riflettervi attorno; e ciò vale anche per i titoli colpevoli di aver venduto milioni di copie senza reinventare la ruota.
AAS
NOTE:
1 Questa volta non c’è nemmeno l’ipocrisia di un videogioco che parla di lotta al capitalismo mentre lo studio finisce a chiedere crunch ai propri dipendenti, cosa che Guerrilla non ha fatto.
2 “La loro differenza dev’essere compresa entro un indice storico: il godimento, come si dà all’interno del discorso del capitalista, è il regime del desiderio completamente asservito alla logica del capitale, da cui le sue componenti mistiche, rivoluzionarie e utopiche vengono detournées, deviate ed estorte, oppure deformate in modo tale da poter essere messe a servizio della teologia del danaro. Alla mistica dell’amor cortese, «che mai non fina», si sostituisce la ricerca ansiosa dell’ultimo gadget.”
Trovate il resto qui.
3Ci sarebbe da aprire una lunga parentesi sull’accoglienza riservata a Citizen Sleeper (Jump Over The Age, 2022), percepito come una critica molto feroce al capitale mentre è, a conti fatti, assai più morbida di quella presente in Forbidden West. Ma la abbiamo, in parte, già formulata.
COMMENTA SU TELEGRAM
SUPPORTACI SU KO-FI